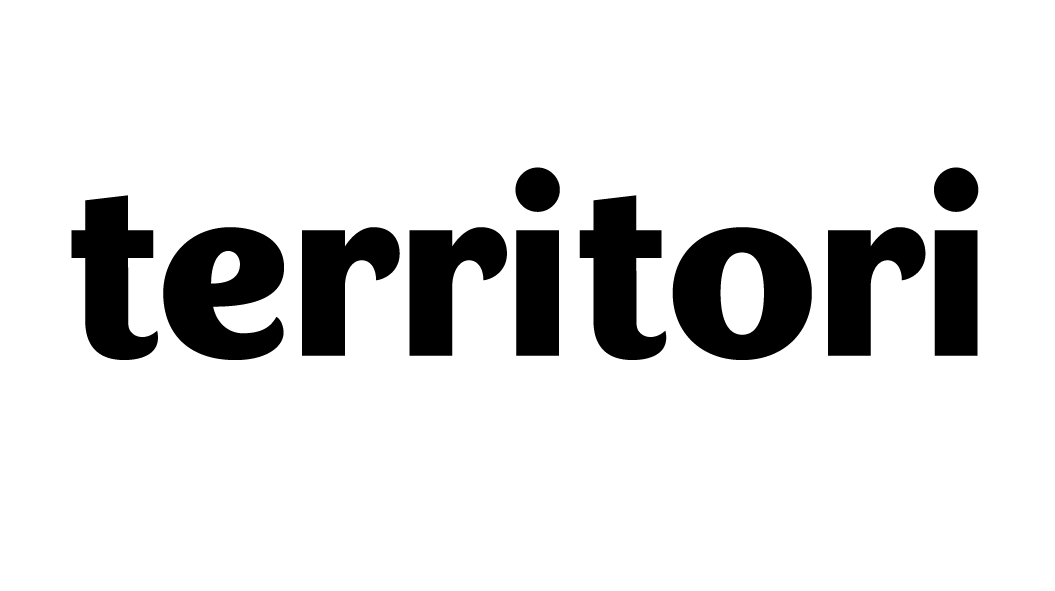11 Dic “Nomos” e “Origine”: intervista a Luca Porqueddu

Intervista di Elisa Cautilli
Luca Porqueddu, parallelamente all’attività di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università “La Sapienza” di Roma, da alcuni anni sta intraprendendo un’interessante attività curatoriale che chiama alcuni giovani architetti da tutta Italia a rispondere su alcuni temi urgenti della contemporaneità. La mostra Nomos, esposta il 4-5-6 settembre 2015 presso le Grandi Cisterne Romane di Fermo e la mostra Origine, che ha avuto luogo dal 20 aprile al 22 maggio 2016 all’interno del quadriportico della Basilica di San Clemente a Roma, sono state i primi passi di un cammino che mostra sorprendenti ambiti di esplorazione.
Elisa Cautilli – Nomos e Origine sembrano configurare il principio di un percorso di ricerca impostato sulla collaborazione e il dialogo tra diversi architetti. Quanto sono importanti nella contemporaneità le occasioni di dialogo e di confronto nel nostro ambito?
Luca Porqueddu – Entrambe le mostre sono pensate come “progetti”, che definiscono il tentativo di armonizzare o, comunque, di generare un confronto, non solo tra opere, ma tra pensieri e poetiche appartenenti a differenti architetti. Sappiamo bene che, a fronte di una realtà fortemente caratterizzata dalla facilità di comunicazione e condivisione “virtuale” delle informazioni, assistiamo alla paradossale segregazione delle esperienze concrete. Ciò accade in modo particolare per l’architettura che, soggetta alle pressioni dovute all’evidente cesura tra le richieste dettate dalla professione e la volontà di maturare una significativa ricerca poetica, non sembra sufficientemente capace di costruire un “luogo d’incontro per l’immaginario degli stessi architetti. Se vogliamo dunque parlare di un percorso comune alle due mostre, ritengo che questo sia da individuarsi nel loro trarre significato dalla volontà di intessere relazioni e legami tra opere e persone. Tutto questo non con l’intento di definire “scuole di pensiero”, ma con l’idea di potenziare le differenti ricerche tematiche e problematiche attorno all’architettura e le conseguenti modalità di espressione.
E.C. – Nomos, la prima di queste due mostre in ordine temporale, ha chiamato dieci architetti a esporre la loro opera all’interno delle Grandi Cisterne Romane di Fermo. Esiste un legame tra il significato di ciò che il luogo rappresenti e il tema dell’esposizione?
L.C. – Socrate e Platone individuano nel nomos un principio organizzativo antitetico alla legge della natura. Il suo intento civilizzatore ed egualitario si sovrappone alla logica selettiva della physis, dalla realtà scandita dalla nascita, dalla crescita, dalla morte e dalla sopraffazione proprie degli esseri viventi. Con tale accezione il nomos si identifica con l’architettura, la quale propone ordini spaziali, funzionali e simbolici della vita umana. Nello specifico della mostra, la scansione regolare e simmetrica che contraddistingue gli spazi delle Grandi Cisterne Romane definisce un principio d’ordine metrico, statico e fisico. In passato il ruolo di quegli spazi era, infatti, quello di definire una struttura tettonica, non solo capace di sorreggere sé stessa, ma anche atta a dominare e organizzare la pressione esercitata dall’acqua. Un’architettura, dunque, intesa come nomos capace di dominare la physis, l’ordine naturale. Parallelamente le opere selezionate per il progetto espositivo esprimono, ognuna a suo modo, la possibilità di individuare un ordine intermedio, capace di indagare una condizione propriamente contemporanea, quella della simultaneità tematica ed espressiva di opere linguisticamente differenti e, al tempo stesso, di azionare un cortocircuito temporale tra l’ordinamento ingegneristico delle cisterne, risalenti probabilmente al I sec. A.C., e interventi attuali, fusi in una nuova dimensione significante.
E.C. – Quanto, in Nomos, l’individualità della singola esposta ha trovato coerenza all’interno di un progetto che si presenta come una mostra collettiva, che ha l’ambizione di indagare un tema ben preciso?
L.C. – Ogni volta che interrogo artisti e architetti su un tema di indagine, oggetto delle mie riflessioni, lo faccio con reale curiosità. Questo significa lasciare la massima libertà espressiva nell’interpretazione e nella formalizzazione del tema. Ritengo che il nostro tempo ci abbia insegnato due cose fondamentali: accettare e amministrare la compresenza di temi e linguaggi, e cogliere abilmente differenze impercettibili, dietro le quali spesso siamo in grado di individuare valori immensi e inesplorati. Tali insegnamenti costituiscono un campo di indagine tanto vasto quanto sensibile, per la sua capacità di misurare le infinite e sottilissime oscillazioni dell’arte. Nella sua estrema complessità, la dimensione appena descritta è una sostanza che attende analisi e descrizioni più profonde di quelle attuali. Troppo spesso il relativismo, il caos e la competizione si ergono a simboli della contemporaneità. Al contrario io rilevo commoventi potenzialità di ascolto e capacità di definire laiche forme di armonia. Questo vogliono dimostrare le dieci opere esiste all’interno delle grandi cisterne romane: la capacità di parlare all’interno di un coro, ma in un dialogo che consente di intuire spontaneamente la potenzialità relazionale della voce solista. Certo trovare un comune denominatore non è semplice e, forse, non è richiesto. Sicuramente, come tutte le vere ricerche, l’operazione comporta rischio e fatica.


E.C. – In riferimento alle due mostre, qual è stato il criterio per la scelta degli architetti coinvolti?
L.P. – Il principale criterio è la qualità dell’opera che è legata con un filo diretto alla qualità della ricerca. Ovviamente il fatto che tutti gli architetti siano dei “giovani architetti”, non è un dato casuale. La generazione a cui appartengo, quella dei progettisti tra i 30 e i 40 anni, attualmente si trova ad affrontare una fase di indagine silenziosa, legata all’evidenza di una crisi economica ed edilizia che obbliga all’attesa e al distacco. Tale condizione mi affascina particolarmente e ritengo sia l’anticamera di una futura maturità espressiva e tematica capace di incidere in modo significativo sulla realtà disciplinare. In totale le due mostre hanno coinvolto quattordici architetti, tra singoli e studi di progettazione. La ricerca di ognuno di loro ha un carattere di estrema qualità e originalità; per questo vorrei citarli uno a uno: Francesco Cianfarani, Pietro Colonna, Filippo De Dominicis, Massimo Dicecca, Bruna Dominici, Kurmak, Giorgios Papaevangeliou, Margherita Pascucci, Tiziana Proietti, Ultra Architettura, Michela Romano ed Emilia Rosmini, Stefano Sciullo, StudioErrante Architetture e Gabriele Trovè.
E.C. – Le due mostre sono state ospitate in spazi dal forte valore architettonico, luoghi che hanno una loro storia e una funzione specifica, uno spazio sacro e una cisterna romana, molto lontana da quella dello spazio espositivo tradizionale. Che valore ha il concetto di luogo nelle due esposizioni?
L.P. – In entrambi i progetti espositivi il luogo assume il valore di un’incognita. Come tale presenta la capacità effettiva di spostare pesi e sensi degli elementi ospitati. Al tempo stesso, il luogo è una dimensione plastica, abile nel declinare alcuni suoi aspetti se provocato da intromissioni significative. Da questo punto di vista, entrambe le mostre riflettono sul modo con cui questa “capacità provocatoria” sia in grado di individuare valori, originariamente non appartenenti né all’oggetto, tantomeno al contesto, ma scaturiti da una relazione, da una deformazione plastica, da un adattamento inaspettato, prevedibile solo attraverso l’intuizione. Nel caso di Nomos alla relazione storica e spaziale tra opere e ambiente si aggiunge una componente fenomenologica determinante che, come un filtro, altera la percezione dei contenuti e attiva trasformazioni fisiche e temporali solo parzialmente prevedibili. La presenza dell’acqua e il forte tasso di umidità dell’aria costituiscono elementi che incidono non solo sull’esperienza del fruitore, ma vengono accolti dai progettisti come ulteriore materiale costruttivo della loro opera. Origine, in modo più concettuale, dialoga con il luogo riflettendo sul tema della stratificazione temporale che trova evidenza nell’intromissione di una nuova fase costruttiva, sedimentata sulle precedenti. A questo si deve la scelta di disporre le opere come se fossero delle presenze coprenti, adagiate su una superfice da nascondere e al tempo stesso da completare. Questo avviene senza trascurare importanti aspetti geometrici e materici del luogo, legati alla proporzione e al ritmo delle colonne della Basilica e alla loro sensibile diversità.

E.C. – Al tempo stesso i due luoghi di cui si sta parlando sono molto differenti tra di loro, sotto i profili architettonico e spaziale, ma anche dal punto di vista dei significati “spirituali”. Si tratta, infatti, l’una di un’antica cisterna romana, un’opera di ingegneria idraulica, e l’altro di uno spazio sacro, attualmente dedicato al culto. C’è stata differenza nella modalità di allestimento?
L.P. – Il principio che guida entrambi i progetti espositivi è quello di evitare la presenza di un allestimento che rimandi ad una condizione “performante”, pronta all’uso. Per questo sono eliminati tutti quegli elementi di mediazione che solitamente facilitano la lettura didascalica ed empatica dell’opera esposta. In questo modo l’esposizione non costituisce una persuasione momentanea dell’osservatore, ma diviene fatto strutturante del luogo, partecipando a tutti gli effetti alla definizione di una nuova realtà. Da questo punto di vista è importante considerare come entrambe le mostre abbiano per oggetto l’architettura, non solo quella strettamente legata alle opere coinvolte, ma soprattutto quella che risignifica integralmente lo spazio attraverso il progetto. Ovviamente, questa visione si declina diversamente a seconda degli stimoli offerti dai due luoghi. Orine è una mostra che dialoga con la luce del sole, in cui il colore chiaro del travertino si staglia sul ciottolato del travertino si staglia sul ciottolato sicuro del quadriportico della Basilica di San Clemente. AL contrario Nomos interagisce con un ambiente oscuro e deformato dalla presenza variabile dell’acqua, nella forma liquida e di vapore. Tuttavia entrambi i progetti espositivi, seppur in modo differente, si confrontano con la dimensione del sacro. Nella Basilica di San Clemente questo avviene in modo più strutturato, attraverso un parallelismo tra la collaborazione statica propria dei conci di cui si compone la muratura lapidea e la relazione significante che secondo San Paolo lega le membra del corpo umano nella metafora della Chiesa. Nelle Grandi Cisterne di Fermo è l’inspiegabile sopravvivenza dell’architettura e delle dieci opere difronte all’incessante pressione della natura a rappresentare una speranza che si rinnova quotidianamente e che nel sacro custodisce il desiderio di immortalità.
E.C. – La mostra Origine presenta quattordici installazioni riconducibili a setti murari in travertino, ognuno caratterizzato da una differente apparecchiatura dei conci, Quali erano gli intenti di questa operazione minimale e quali sono stati i risultati rispetto agli obiettivi iniziali?
L.P. – Tendo a pensare che l’origine di un’architettura si possa individuare nel sublimare l’urgenza costruttiva in volontà espressiva. Origine cerca di esprimere questo concetto forse di troppo semplice, ma proprio per questo non sufficientemente indagato nella contemporaneità. Spesso le evidenze sono il luogo dei maggiori fraintendimenti, così quei principi che dovrebbero rappresentare delle certezze rivelano una fragilità commovente quanto destabilizzante. La domanda alla base della mostra è elementare: la contemporaneità architettonica è ancora capace di esprimersi attraverso una sintesi significativa di aspetti costruttivi e di necessità espressive? È interessante constatare come questo presupposto sia costantemente disatteso dalla pratica architettonica corrente e, al tempo stesso, quanto questa semplice e banale domanda possa ancora stimolare l’immaginario architettonico. Le opere in mostra ne sono esempio.
E.C. – A cosa si deve la scelta del materiale lapideo come riferimento nella mostra Origine?
L.P. – Origine è parte del programma culturale di Stonetales, nato dal dialogo tra Università e industria, con l’obiettivo di sensibilizzare la cultura architettonica contemporanea nei confronti delle potenzialità tecniche ed espressive dei materiali lapidei. Con questo programma l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, nello specifico la facoltà di Ingegneria, l’associazione Lab. 2.0. e l’azienda Carlo Mariotti & Figli hanno collaborato, ognuno nel suo specifico settore, alla definizione di una mostra che fosse anche capace di raccontare il processo produttivo che dall’estrazione del travertino giunge fino alla trasformazione della stessa pietra in prodotto artistico e architettonico. Oltre a queste necessarie premesse collaborative, la pietra è stata scelta per la predisposizione naturale alla narrazione di due temi a cui sono particolarmente legato: il tempo e il sacro.



E.C. – Cosa ha comportato, a livello tecnico ed espressivo, la scelta dell’utilizzo della pietra come materiale per la creazione delle opere esposte?
L.P. – Le opere presentate nel progetto Origine son realizzate appositamente per la mostra. Non tutti gli architetti coinvolti lavorano abitualmente con la pietra, ciò ha comportato l’esigenza di dialogare costantemente con l’azienda Carlo Mariotti & Figli, sia in fase di progettazione, che di realizzazione delle opere. L’architettura è una disciplina in cui gli aspetti tecnici sono fondamentali, e la sintassi della pietra presenta numerose regole la cui conoscenza è determinante per l’arte del costruire. Si tratta di un insieme di vincoli e di possibilità che incidono in modo significativo sugli aspetti espressivi. Lo spessore di una lastra, la levigatezza di una superficie, l’andamento della venatura, cosi come le sensibili differenze cromatiche e di densità del travertino, sono elementi sostanziali, la cui capacità comunicativa ha una matrice prettamente tecnica.
E.C. – Nel progetto Origine le apparecchiature murarie sono disposte in senso orizzontale. Come si spiega il motivo di tale scelta?
L.P. – Sappiamo bene che la sfida dell’architettura è quella di materializzare il miracolo dell’annullamento del “peso”. Rimaniamo stupiti davanti al gigantismo di molte costruzioni del passato e della contemporaneità, che esprimono l’esigenza non solo di abitare, ma anche di costruire simboli di questa sfida. Migliaia, milioni di tonnellate di materia sono organizzati in modo che siano capaci di collaborare e definire strutture resistenti. Così nel corso dei secoli l’architettura ha ideato conformazioni capaci di indirizzare, in modo sempre più efficiente, le forze legate al dialogo tra la massa e la gravità. Tra tutte queste configurazioni, per dare corpo alla mostra, è stata scelta la più semplice, una muratura, la cui struttura, una volta posizionata in orizzontale, è stata privata dall’azione coesiva della forza peso. Si tratta di innescare un paradosso statico per il quale, alla forma progettata per essere costruita, viene negata la possibilità di funzionare come struttura tettonica. Questo consente a chi osserva l’opera di riflettere sul valore di quella presenza, non solo come testimonianza di un sapere tecnico, ma anche come puro fatto estetico.
E.C. – Cosa c’è in programma dopo Nomos e Origine?
L.P. – Attualmente mi interessa il modo con cui il lavoro degli architetti sia in grado di trasmettere la forza di contenuti altamente significativi attraverso operazioni impercettibili, Trovo commuoventi le minime deviazione nella traiettoria capaci di introdurre spaesamenti. Ho sempre più l’impressione che ci sia molto rumore dal quale in un certo qual modo dobbiamo imparare a difenderci. Non penso tuttavia che il prossimo progetto sarà un’operazione difensiva. Probabilmente non si porrà come obiettivo il frastuono.