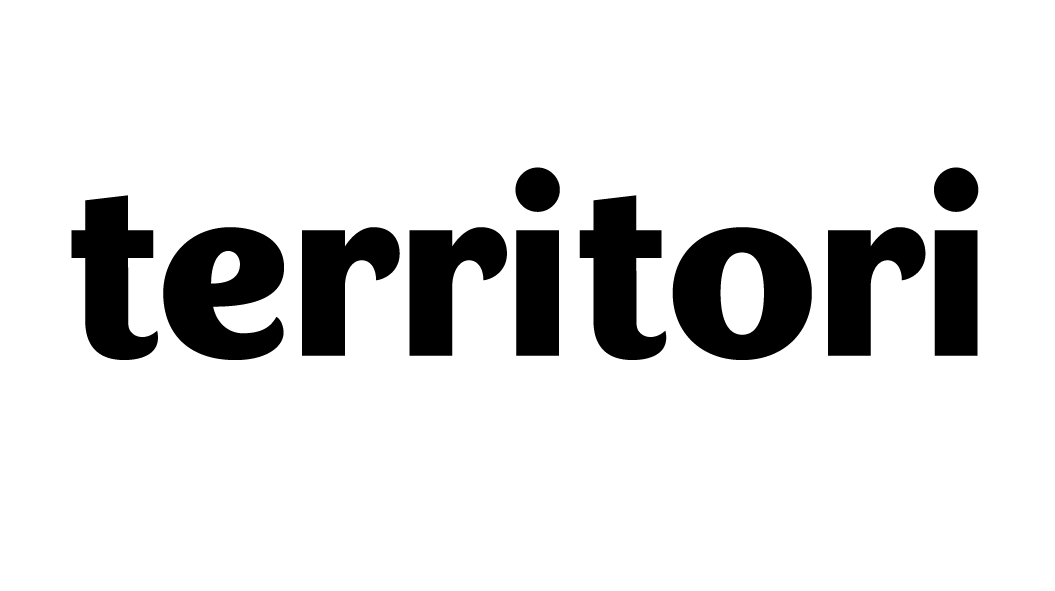27 Dic Tre progetti dello studio MCM a Sora
Articolo di Pierluigi Fiorentini
Lo studio MCM, composto da Renato Morganti, Gianfranco Cautilli a Mario Morganti, è attivo a Sora da circa trent’anni e vanta un curriculum ricco di realizzazioni e progetti di notevole interesse.
Tra le numerose realizzazioni ricordiamo soltanto il restauro del castello Caietani a Trevi nel Lazio, il restauro della rocca di San Casto e Cassio a Sora, il riuso della cartiera Lefebvre a Isola del Liri, il riuso del convento di San Francesco a Sora, esperienze attraverso le quali il gruppo ha approfondito nel tempo una linea di ricerca ben precisa e ha costruito una sua identità ormai ben riconoscibile.
Maturando una lunga esperienza nel restauro e riuso di edifici storici, il gruppo ha così affinato una strategia di intervento che è attenta ai valori spaziali e alle qualità costruttive dell’esistente, ma riesce nello stesso tempo a manifestare concetti spaziali assolutamente nuovi attraverso l’impiego di materiali, tecnologie, principi costruttivi desunti dalla tradizione moderna e reinterpretati in maniera originale. Le “riletture” dell’esistente operate da MCM riprendono una linea di ricerca, aperta in Italia a partire dagli anni ’50 del ‘900 da Franco Albini e Carlo Scarpa, che forse rappresenta uno dei migliori contributi italiani al dibattito architettonico in Europa nel secondo dopoguerra. Seppure limitate al settore della museografia, le esperienze di Scarpa nella sistemazione del museo di Castelvecchio a Verona e di Albini nella sistemazione di Palazzo Rosso a Genova hanno indicato alle successive generazioni di architetti una direzione da indagare e da approfondire, ricca di spunti e suggestioni e tuttavia piena di nodi tematici di notevole complessità.
Tra le tematiche principali all’interno di questa ricerca: la lettura critica e la reinterpretazione del manufatto da recuperare, la sperimentazione intorno ai modi adeguati e alle tecniche appropriate per il suo consolidamento, la riflessione attenta sulla nuova attribuzione di senso, il progetto di elementi, parti, organismi nuovi, chiamati a dialogare e interagire con l’esistente, il perseguimento di una riconoscibilità degli interventi contemporanei all’interno degli edifici storici.
Nel corso degli anni i progettisti del gruppo MCM hanno instancabilmente perseguito una ricerca a tutto campo nell’uso dei materiali e nell’impiego delle tecniche costruttive, attraverso cui hanno saputo mettere a punto forme nuove e soluzioni originali con l’obiettivo di piegare le necessità della tecnica e della statica fino a trasformarle in invenzioni duttili, sorprendenti, al di fuori di ogni convenzione. Così ogni occasione viene affrontata come se lo si facesse per la prima volta, con la stessa curiosità e freschezza, non con la sciatteria e la stanchezza cui ci porta l’abitudine, evitando di cedere alla banalità del già visto, di fermarsi alla sicurezza del già sperimentato, senza dar nulla per scontato.
In questo testo prendiamo in considerazione tre progetti completati dallo studio negli ultimi anni nella città di Sora: il museo archeologico, il sepolcreto dei vescovi presso la cattedrale, la sistemazione di Piazza Meyer Ross.
Appare subito evidente come alcuni di questi progetti presentino una forte continuità con le esperienze precedenti, nel senso che in essi il gruppo ha approfondito temi già affrontati e ha arricchito una ricerca già intrapresa da tempo.
Sia nella sistemazione del museo archeologico, sia nel sepolcreto dei vescovi emerge infatti, come idea forte generatrice del progetto, il principio che la forma si costruisce come intreccio di linguaggi tenuti rigorosamente distaccati, distinti, leggibili nella loro autonomia, in modo da giocare sulla tensione incontenibile che promana proprio dalla loro distanza: il linguaggio leggero, trasparente, moderno dell’acciaio contro quello pesante, opaco, antico della pietra; il linguaggio razionale delle forme astratte contro quello organico delle murature, legate alle irregolarità nella morfologia del sito. Intorno a questo motivo, vero e proprio fil rouge nel proprio percorso professionale, il gruppo MCM ha sviluppato un suo contributo di straordinaria coerenza.
Nella terza realizzazione, la sistemazione della Piazza Meyer Ross, appaiono invece motivi e interessi nuovi che emergono forse per la prima volta. Qui, in particolare, il rapporto critico tra preesistenze e architettura nuova viene sviluppato a un livello più ampio, fino a coinvolgere a pieno il tema del paesaggio e la relazione con il contesto naturale.
Museo archeologico della media Valle del Liri a Sora
Il progetto affronta il riuso di quella parte dell’ex convento di San Francesco destinata a Museo archeologico della media valle del Liri.
Il complesso monumentale è stato oggetto di un lungo intervento di recupero attuato in più fasi.
Il museo rappresenta la fase più recente, ultimata con la riorganizzazione degli spazi destinati all’esposizione permanente di reperti e documenti relativi al periodo che va dal III secolo a.C. alla prima metà del XX secolo.
Gli spazi dell’antico convento francescano vengono riutilizzati per esporre pezzi antichi rinvenuti nel corso degli anni nel territorio del sorano, ma anche resti del Quattrocento recuperati da recenti demolizioni e un ricco repertorio di immagini relative alla città di Sora nei primi anni del 1900.
L’istituzione si pone quindi come un vero e proprio “museo della città”, che custodisce tracce, documenti, memorie relative alla successione e alla sovrapposizione nel territorio di Sora di culture e segni diversi attraverso i secoli. La città europea come palinsesto, riscrittura continua di un’opera corale destinata a restare incompleta, sempre disponibile a nuove interpretazioni.
E proprio questa è l’idea che sta alla base dell’intervento sull’antico convento di San Francesco: la città è un palinsesto di cui sarebbe inutile cercare l’autore, poiché è frutto di una continua riscrittura realizzata in tempi diversi, da autori diversi e con lingue diverse. Chi progetta è chiamato a inserirsi all’interno di questa continua riscrittura, mettendo in gioco la sua cultura e suoi valori, le sue tecniche e i suoi materiali per intrecciarle e confrontarle con quanto già scritto.
Il progetto del museo conferma l’antico impianto, lascia inalterati gli spazi nella loro essenzialità, riorganizza i percorsi, disponendo laddove possibile i connettivi necessari a rendere funzionale l’insieme.
L’intervento di Morganti e Cautilli risulta convincente forse perché alla sua base riconosciamo quei valori autenticamente contemporanei che Calvino descrive in maniera magistrale in “Lezioni americane”: “leggerezza”, “rapidità”, “esattezza”, “visibilità”, “molteplicità”.
All’interno del complesso monastico esistente i nuovi elementi in acciaio dispiegano un linguaggio leggero, rapido, esatto, che, piegato alle esigenze imposte dagli spazi esistenti e dagli oggetti da esporre, riesce a mostrarsi anche straordinariamente duttile e discreto.
Abbandonata ogni durezza e ostentazione muscolare di potenza, mostra invece una materialità che tende alla rarefazione, un’agilità che è fatta di grafismi e trasparenze. All’interno degli spazi dell’edificio la nuove “scrittura” risulta perfettamente leggibile e dunque ha una sua chiarezza e una sua “visibilità”. Confermando un principio ormai consolidato della museografia e del restauro, ogni nuovo elemento introdotto all’interno dell’edificio risulta perfettamente riconoscibile, acciaio contro muro, leggero contro pesante, come pure perfettamente riconoscibile è l’oggetto antico esposto attraverso l’apparato ostensivo. Quest’ultimo riesce a isolare l’oggetto esposto dallo sfondo, a strapparlo dalla specifica situazione spaziale e a proiettarlo in una condizione di astrazione assoluta e di atemporalità.
Infine il senso di “molteplicità” scaturisce proprio dall’idea di fondo, secondo cui il progetto si costruisce dall’intreccio di più voci, antiche e moderne, gravi quelle dei muri, squillanti quelle degli inserti in acciaio.


Recupero del sepolcreto della cittadella vescovile di Sora
Il progetto riguarda il recupero dell’antico sepolcreto, che fa parte del complesso architettonico della cattedrale di S. Maria Assunta di Sora.
Più precisamente si tratta di uno spazio situato al livello inferiore della cosiddetta “Cappella del Purgatorio”, definita nella sua attuale configurazione nella seconda metà del Settecento.
Il sepolcreto è uno spazio parzialmente interrato a pianta rettangolare, coperto con due volte a botte a giacitura parallela, entrambe sostenute da un grande arco centrale. Usato in antico per le sepolture comuni, è stato liberato dalle superfetazioni, riportato alla originaria unitarietà e recuperato per accogliere la cappella sepolcrale vescovile.
Anche in questo progetto troviamo il tema dell’architettura nuova che deve confrontarsi con uno spazio e un’architettura già esistente. E la chiave utilizzata dagli architetti, in coerenza con la lunga ricerca condotta dal gruppo, è ancora una volta il distacco, l’aperta manifestazione di un’alterità irriducibile. Così all’interno dell’organismo murario che delimita e copre lo spazio, gli architetti inseriscono i nuovi volumi delle tombe, concepiti come parallelepipedi puri, rivestiti di lastre di travertino tagliate “a falda”, facendo attenzione che le nuove forme si avvicinino alla struttura esistente senza toccarla; in modo che lo spazio si arricchisca della compresenza di due linguaggi diversi, che si intrecciano ma non si confondono, forma astratta contro forma costruttiva tradizionale.
Ma inevitabilmente troviamo qui altri accenti che sono legati unicamente al tema della sepoltura e le scelte linguistiche si caricano di significati che rimandano a una meditazione profonda sull’essenza universale della morte.
Il linguaggio diventa minimale e attinge direttamente al mondo delle idee platoniche e dei solidi elementari: i volumi delle sepolture sono bianchi parallelepipedi di pietra, come pure l’altare. Il tono si fa grave e ogni “parola” in più appare inefficace: viene meno così qualsiasi ornamento, ogni vivace composizione di forme e colori cede il passo al silenzio. Il modo scelto per rappresentare la morte non è narrativo, né consolatorio: laddove le parole non bastano per descrivere una dimensione che non ci è dato conoscere, occorre fare un passo indietro, rinunciare alla lingua in una sorta di “epochè”, sospendere ogni giudizio. Il vuoto di Caravaggio contro l’esuberanza berniniana. Dal mondo della vita, del continuo divenire, della molteplicità delle forme e dei colori, ci si sposta quindi verso la dimensione dell’assoluto e dell’immutabile, qualcosa che forse in termini architettonici può essere descritto solo percorrendo la via della rarefazione concettuale, solo realizzando una riduzione all’essenza che porti al “quasi nulla” miesiano.
Sistemazione di Piazza Meyer Ross a Sora
Il progetto di riqualificazione investe un’area urbana situata ai piedi del colle San Casto e Cassio, emergenza naturale che domina il centro storico della città. Il sito, anticamente utilizzato come orto del vicino convento francescano, era stato edificato negli anni ’60 del ‘900 con la costruzione di un cinema-teatro per 1600 spettatori, un volume ingombrante e sovradimensionato che, chiudendo la piazza verso il colle, recideva di fatto qualsiasi relazione con il contesto naturale.
Dopo una lunghissima fase di studio, di riflessione e di valutazione di differenti ipotesi progettuali, la proposta finale del gruppo MCM appare coraggiosa e radicale: essa prevede la demolizione dell’ex cinema-teatro e il ridisegno del limite inferiore della rupe con la realizzazione di un’architettura dimensionalmente adeguata e di notevole livello qualitativo. E’ motivo di speranza riconoscere che in questo caso le logiche speculative, mosse dall’obiettivo del massimo profitto e della massima volumetria, hanno ceduto il passo rispetto all’esigenza di ridare senso e qualità a un luogo centrale dell’organismo urbano.
Uno dei tratti più forti del progetto è il tentativo di ricostruire una relazione stretta con il paesaggio naturale. La montagna è lo sfondo su cui si innesta la nuova architettura. L’edificio prima che volume vuole essere una sorta di muro di contenimento, il cui aspetto presenta la chiusura e la compattezza della roccia: dallo spazio urbano ciò che si percepisce dell’edificio ha il colore, l’opacità, la pesantezza della roccia e della montagna ben visibile sullo sfondo. Con i materiali scelti, il travertino, l’acciaio corten, il prato che copre il solaio di copertura, i progettisti vogliono quasi costruire un pezzo di paesaggio, vogliono completare lo scenario naturale della montagna, definendone la parte basamentale. L’architettura assume dunque una morfologia che la rende quasi parte del paesaggio naturale: anche le pareti sembrano non obbedire a leggi geometriche razionali, ma si adagiano su linee e giaciture che le avvicinano all’aspetto spigoloso e cristallino della roccia. Visto dalla piazza il manufatto non ha nulla di ciò che normalmente chiamiamo “edificio”: mancano porte o finestre convenzionali chiaramente riconoscibili, manca un tetto a falde o una copertura piana. Proprio come la montagna, il manufatto si lascia invece percorrere esternamente grazie a un sistema di rampe che connette lo spazio urbano alla rete dei sentieri che conducono sulla cima del colle San Casto.
Ma la sorpresa che coglie l’osservatore, quando attraversa l’ingresso discretamente incastonato nella facciata ed entra finalmente nello spazio interno, è forse l’esperienza più forte ed esaltante.
Tanto possente, materica, impenetrabile appariva l’architettura dallo spazio urbano, quanto trasparente, leggero, luminoso, si rivela ora l’interno. A riempire il campo visivo è una grande parete vetrata aperta verso il piede roccioso della montagna, sul cui sfondo luminoso si staglia il disegno triangolare della struttura portante a traliccio, realizzata in grandi tubolari di acciaio. Gli architetti hanno abbandonato il linguaggio pesante e opaco della pietra e della terra, per adottare quello leggero e trasparente del vetro e dell’acciaio. Ci rendiamo conto quindi che a guidare i passi del fruitore è un gioco di continui rimandi e di corrispondenze, di affinità e di contrasti, basato sull’antitesi, sulla compresenza o sulla sovrapposizione dei concetti opaco-pesante contro trasparente-leggero. E all’interno della sala tale contrasto raggiunge il momento di massima tensione. Lo spazio interno sembra esser stato concepito come una cavità profondamente radicata nella terra, nascosta, accogliente e protettiva, ma al tempo stesso proiettata verso l’esterno, aperta verso la luce naturale e verso il cielo.
Se dovessi indicare quali possano esser state le architetture di riferimento assunte dagli autori durante il progetto, citerei la Villa Malaparte di Adalberto Libera, alcune folgoranti intuizioni di Hans Scharoun e poi, ancora, Aalto e Siza. Ma tuttavia tali rimandi appaiono soltanto come vaghe assonanze, tanto ha pesato la necessità di cercare la soluzione più appropriata alle particolarità del contesto specifico attraverso un’architettura cesellata sui caratteri del luogo.