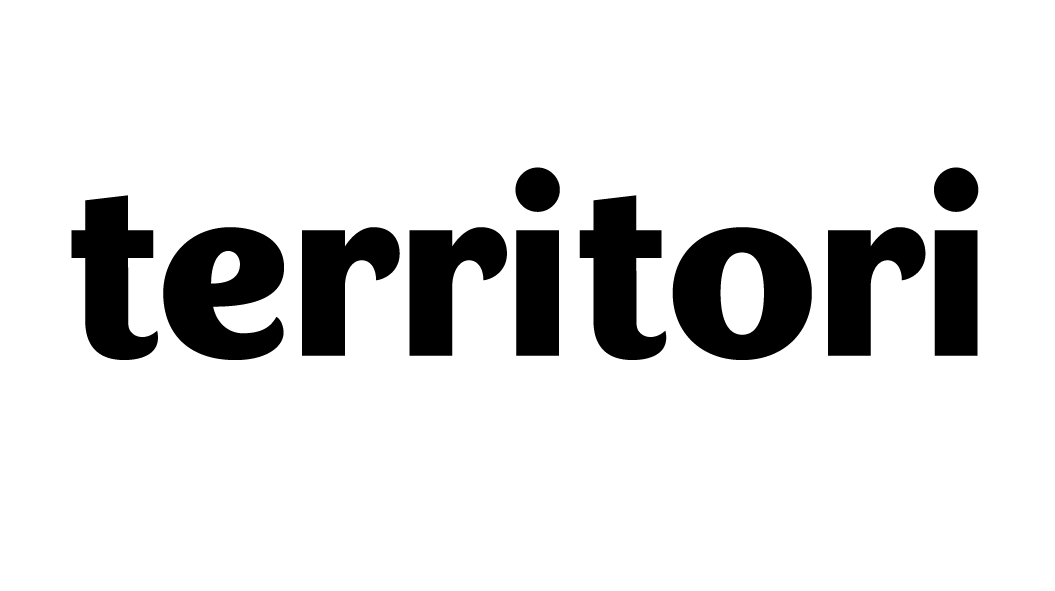07 Gen Architettrici: femminile, plurale
Articolo di Giovanni Fontana
Architettrice! Il costume di volgere al femminile i sostantivi che designano ruoli professionali sta prendendo piede stabilmente. Si tratta di una tendenza che, nel suo piccolo, contribuisce a fare chiarezza in un territorio aspro ed accidentato, che per secoli ha voluto escludere la donna da gran parte dei ruoli civili, riservando a lei solo mansioni di comodo, compatibili, secondo l’ottica maschilista dominante, con la veste di moglie e di madre. Del resto gli stereotipi di ruolo vengono ancora oggi ampiamente confermati e consolidati dai processi di socializzazione e dal forte influsso culturale delle principali religioni: cristianesimo, giudaismo, islamismo, induismo.
Intralciare il cammino delle donne è una costante secolare, diffusa in ogni angolo del mondo. Preclusioni, giudizi ostativi, divieti a norma di legge o tradizioni incancrenite nell’ignoranza e nella violenza fisica e psicologica, costumi illogici, incomprensibili, dispotici, dettati da fondamentalismi prevaricatori dei più elementari diritti dell’essere umano. Come ben noto, tutto questo e quant’altro è il frutto di una stratificazione di usi e costumi legati alle discriminanti che con il tempo hanno partorito mostri socio-giuridici secondo cui sussisterebbe una differenza di natura tra uomo e donna che giustificherebbe una diversità di trattamento, in barba a qualsiasi principio di natura scientifica e morale. Si è andati avanti così per secoli.
In Italia, un passo risolutivo lo ha fornito l’art. 3 della Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, che sancisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini «eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». A Parigi il 10 dicembre dello stesso anno, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvava e proclamava la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR). Fu una tappa fondamentale nel processo, quanto mai difficile, per l’affermazione universale del diritto e per la difesa della dignità umana. Il documento regola i rapporti civili tra gli esseri umani, al di là di ogni eventuale barriera di carattere politico, economico, sociale, culturale, religioso, che, già nel preambolo afferma la propria fede nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna.
All’art. 1 si legge: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».
All’origine, questo articolo decretava, così come voluto da Eleanor Roosevelt: « All men are born free and equal in dignity and rights». Ma Hansa Mehta, scrittrice ed educatrice indiana, esponente del movimento per la libertà secondo i principi del Mahatma Gandhi, in qualità di delegata indiana alla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 1947-1948, propose di modificare il testo dell’articolo in quella che è l’attuale redazione: «All human beings are born free and equal in dignity and rights». Non più «tutti gli uomini», bensì «tutti gli esseri umani».
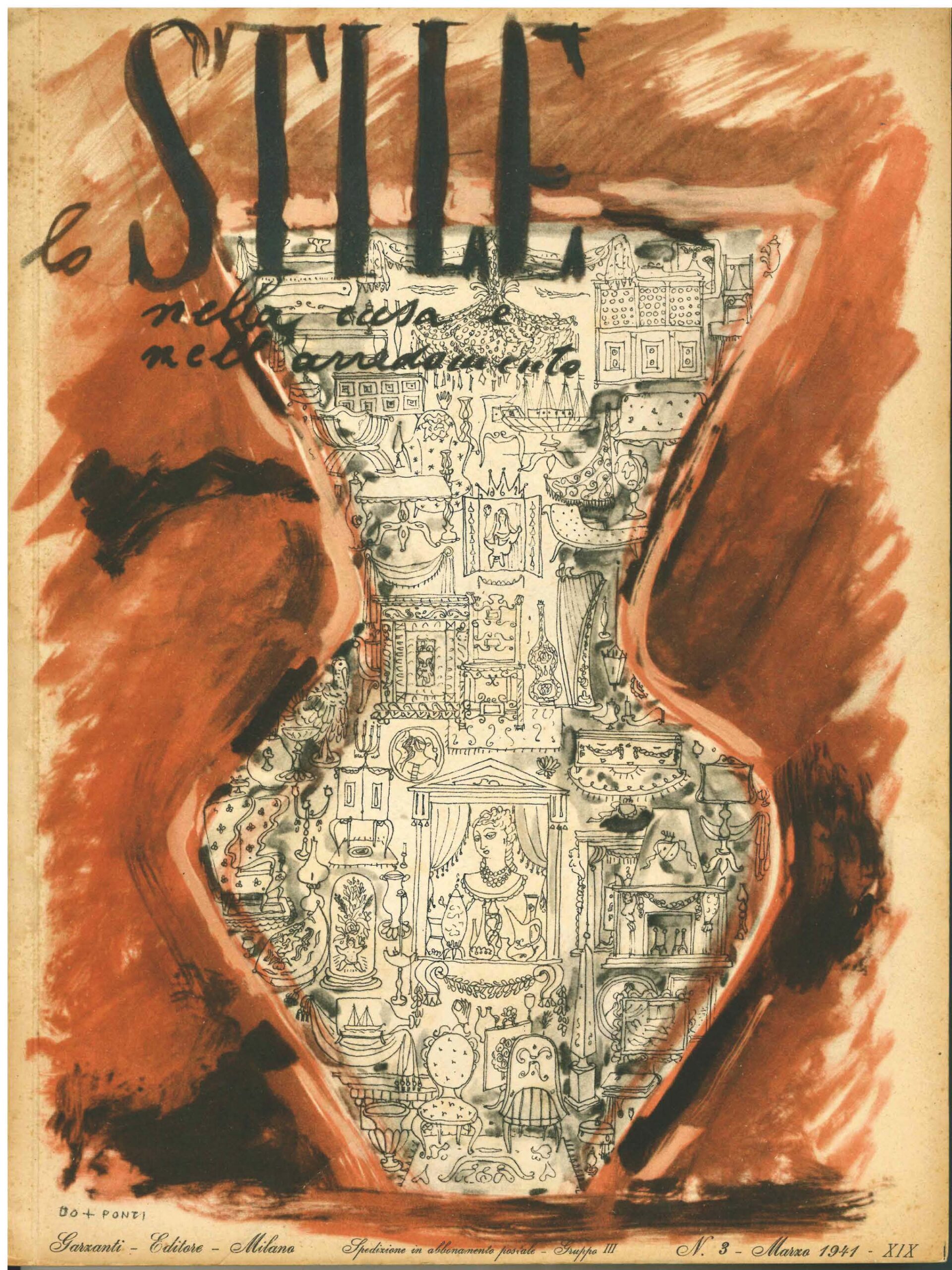
All’art. 2, la Dichiarazione entra nel dettaglio specificando: «Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione […]». Inoltre all’art. 7 è indicato che «Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge […]». Attraversando la sequenza dei successivi articoli, in un’illuminante lezione sull’universale parità di diritti politici, economici, sociali e culturali, indispensabili alla dignità e al libero sviluppo della personalità dell’essere umano, si giunge all’art. 27, dove è scritto a chiare lettere che «Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici».
Tuttavia non è male ricordare che in Italia alcune importanti battaglie per i diritti civili delle donne sono state vinte con grande ritardo. Si pensi che le donne italiane hanno votato per la prima volta in occasione del Referendum istituzionale del 2 giugno 1946, che l’art. 559 del Codice Penale, che puniva con la reclusione esclusivamente la donna se commetteva adulterio, è stato abrogato dalla Corte Costituzionale con sentenze giunte solo nel 1968 (n. 126) e nel 1969 (n. 147); il divorzio viene introdotto nell’ordinamento giuridico italiano solo nel 1970; la parità di trattamento sul lavoro tra uomini e donne viene introdotta nel 1977 (Legge n°903), il delitto d’onore e il matrimonio riparatore sono aboliti soltanto nel 1981 (legge n. 442). Altri diritti sono stati acquisiti con notevolissimi ritardi e tanti ancora sono di là da venire.
 In ogni modo, sia pure con difficoltà, dopo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, numerose altre convenzioni e strumenti giuridici internazionali consentono ai cittadini di far sentire la propria voce presso le Corti dei diritti umani, anche contro i propri stessi stati. Tra questi strumenti assume un ruolo fondamentale la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW, 1979). Si tratta di uno strumento giuridico che apre prospettive innovative riguardo alla discriminazione, soprattutto perché pone il superamento dell’uguaglianza formale con quella sostanziale. La Convenzione introduce diverse misure per l’eliminazione delle discriminazioni in ogni settore, trattando di diritto al lavoro e nel lavoro (art.11), di diritto alla partecipazione e alla vita politica (artt. 7 e 8), di diritto alla salute e alla pianificazione familiare (art.12), di uguaglianza di fronte alla legge (art. 15), di parità nell’educazione e nell’istruzione (artt. 5 e10), nella famiglia e nel matrimonio (art.16), ecc.
In ogni modo, sia pure con difficoltà, dopo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, numerose altre convenzioni e strumenti giuridici internazionali consentono ai cittadini di far sentire la propria voce presso le Corti dei diritti umani, anche contro i propri stessi stati. Tra questi strumenti assume un ruolo fondamentale la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW, 1979). Si tratta di uno strumento giuridico che apre prospettive innovative riguardo alla discriminazione, soprattutto perché pone il superamento dell’uguaglianza formale con quella sostanziale. La Convenzione introduce diverse misure per l’eliminazione delle discriminazioni in ogni settore, trattando di diritto al lavoro e nel lavoro (art.11), di diritto alla partecipazione e alla vita politica (artt. 7 e 8), di diritto alla salute e alla pianificazione familiare (art.12), di uguaglianza di fronte alla legge (art. 15), di parità nell’educazione e nell’istruzione (artt. 5 e10), nella famiglia e nel matrimonio (art.16), ecc.
Ma nonostante gli strumenti giuridici, porre ostacoli alle iniziative delle donne è un’attività che si inserisce purtroppo in quella selezione alla rovescia che stiamo ormai osservando da decenni, dove la mediocrità svetta sulle classifiche, anche sul piano politico e istituzionale. Il merito non conta, la qualità non conta, ma vale invece l’adesione al modello, ahimè, vincente di un uomo che si rivolge al presente con sguardo miope, preoccupato dei suoi meschini giochi di potere, convinto assertore di verità assolute che non lasciano spazio alcuno al confronto corretto e leale e che stenta a riconoscere i propri errori, attaccato ai suoi privilegi ancestrali.
A questo punto, allora, non resta che darsi da fare per combattere questi atteggiamenti operando a tutto campo sul piano sociale e culturale, per promuovere nuove sensibilità, ma segnando i percorsi innovativi con evidenze inequivocabili, che stiano lì, bene in evidenza, a svolgere una funzione di costante richiamo (se non di monito) sul piano non solo simbolico, ma anche funzionale. Ben vengano allora le «quote rosa» o le versioni al femminile dei ruoli professionali o istituzionali, ben vengano opere dell’ingegno creativo come L’Architettrice di Melania Mazzucco, o indagini scientifiche come quella su Plautilla Bricci di Consuelo Lollobrigida, ben vengano iniziative come il webinar promosso dalla Commissione Cultura dell’Ordine di Frosinone sul tema delle architettrici o articoli come quello sull’artista Artemisia Gentileschi di Stefano Manlio Mancini già ospitato sulle pagine di questa rivista, con l’augurio che possano aprire nuovi orizzonti di conoscenza, sotto il segno della chiarezza e dell’imparzialità.